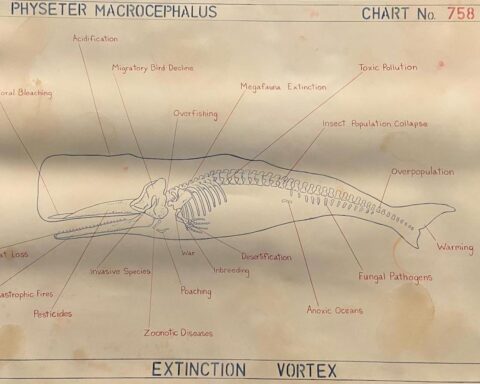Quante volte vi è capitato di aprire un link apparso sui vostri feed di Instagram o Facebook con un titolo simile a: “studente da record: a 25 anni ha già sei lauree, tutte con lode”? Questo titolo è ispirato a un articolo del Messaggero, dove si riporta l’impresa titanica di uno studente della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, ma è solo un esempio di una tipologia di articolo che in Italia è diventato molto in voga negli ultimi anni.
Moltissime le testate giornalistiche che hanno pubblicato articoli dedicati alle eccellenze accademiche, in particolare ragazzi che hanno acquisito una o più lauree in tempi eccezionalmente corti e tipicamente con voti molto alti. Questo tipo di articoli ha suscitato moltissime discussioni, perché, seppure sia giusto elogiare lo sforzo e il successo del singolo individuo, è inevitabile osservare come questa narrativa riguardi un numero ristretto di studenti e che stona di molto con l’umore generale nella scuola e nelle università italiane e non solo.
Vorrei soffermarmi su questo articolo del Messaggero, in particolare sulle parole della rettrice della Sant’Anna sullo studente in questione:
«l’impegno, la tenacia, l’entusiasmo di Samuele sono la dimostrazione che risultati eccellenti possono essere raggiunti e che la propensione all’interdisciplinarietà può nascere in maniera molto precoce negli ambienti che la facilitano»
Questa frase mi ha molto colpito, un po’ perché ha risuonato parecchio con la mia esperienza personale nel mondo accademico, un po’ perché credo che queste tre righe siano indicative della cultura dominante nel mondo dell’istruzione e del lavoro.
Dunque, ho deciso di partire da qui per smontare e riconfigurare sotto un punto di vista diverso il pensiero racchiuso nelle parole della rettrice.
Retorica della tenacia e dell’impegno
Nel suddetto articolo, le leve retoriche del discorso sono la tenacia e l’impegno che portano l’individuo verso il successo e la realizzazione personale. Detto in un altro modo, se hai passione per ciò che fai e lavori sodo, prima o poi il successo busserà alla tua porta. Un ambiente che facilita lo sviluppo della persona è poi un aiuto fondamentale nel raggiungere i propri obiettivi.
Se eccelli nel tuo campo, inoltre, potresti essere notato dalle università migliori del mondo, che ti faranno la corte per averti tra i propri alunni e, se sei davvero molto bravo, magari persino il Presidente della Repubblica in persona ti riconoscerà in veste ufficiale.
Questa è una storia molto bella, e io auguro il meglio al talentuoso Samuele Cannas, ma credo anche che sia giusto offrire una narrativa diversa e controbattere con un punto di vista alternativo.
Comincio col dissentire con il pensiero per cui l’entusiasmo e l’impegno portino sempre ai risultati.
Avete mai considerato che forse, a volte, accade esattamente il contrario, ovvero, che i risultati portino all’entusiasmo?
Un’altra domanda, forse ancora più interessante, potrebbe essere la seguente: è necessariamente vero che l’eccellenza, il duro lavoro a testa bassa, la motivazione e tutte le altre qualità che vengono oggi premiate ci portino sempre verso il traguardo più giusto per noi?
E infine: premere l’acceleratore per laurearsi e inserirsi nel mondo del lavoro in tempi record è sempre utile? È necessario e vitale non fermarsi mai e centrare sempre l’obiettivo? Quanto è perdonabile il fallimento, l’errore?
Per rispondere a queste domande, ci terrei a raccontare degli spaccati di vita nel mondo accademico, che è forse il principale centro di attrattiva per le cosiddette eccellenze, ovvero, ragazzi e ragazze con voti alti, lauree a pieni voti e tanta ambizione.
Cosa accade dietro le quinte di questa realtà di cui i giornali si occupano sporadicamente (e, di solito, per parlare di premi prestigiosi come il Nobel)? Chi sono i ricercatori e come vivono la loro vita sono argomenti necessari per capire il lato oscuro dell’eccellenza scolastica e accademica e, perché no, anche della passione ad ogni costo.
Durante il mio dottorato di ricerca ne ho davvero sentite tante di storie, ma vorrei cominciare con quella che mi ha turbata di più in assoluto. Un giorno stavo parlando con un ricercatore che mi ha raccontato che durante il suo dottorato era solito dormire nel laboratorio per interi mesi durante gli esperimenti.
Immaginatevi un ragazzo di vent’anni che spende dodici ore al giorno in un laboratorio buio, rumoroso, con la responsabilità di strumenti che costano decine di migliaia di dollari, che dopo aver finito il turno srotola un sacco a pelo e si accuccia dietro un compressore a pieno regime nella stessa stanza in cui ha lavorato fino a quel momento.
Immaginatevi che questo si ripeta per mesi interi, quattro o cinque anni di fila, con una paga da fame come unico compenso.
Immaginatevi che questa sia la massima aspirazione che i genitori orgogliosi volevano per lui, un figlio così intelligente e brillante, sempre primo ai test di matematica dalla scuola primaria fino agli ultimi esami universitari. Immaginatevi che questo sia normale, che i tuoi colleghi facciano esattamente lo stesso.
Non andate molto lontano dalla realtà se immaginate anche un’università dove ogni tanto uno studente si butta giù da una delle finestre di un palazzo del dipartimento o un altro non viene rinchiuso in un ospedale psichiatrico.
Immaginatevi – perchè se i giornali non ne rendono immagini vivide serve immaginazione per avvicinarsi alla realtà dei fatti spesso trascurata – interi dipartimenti dove i ragazzi più intelligenti, più motivati, più entusiasti e ambiziosi del paese vivano in condizioni limite e ditemi se credete ancora al mito dell’eccellenza sempre premiata.
Insomma, se questo è realmente il compenso che arriva per duro lavoro e intelligenza, forse è meglio fallire il colloquio di entrata.
Questo aneddoto riguarda un individuo, ma è chiaramente una goccia in un mare di disperazione. Interi dipartimenti di psicologia stanno esplorando il fenomeno della crisi della salute mentale nel mondo accademico, che ormai è un fenomeno riconosciuto, appartenente allo stato dell’arte delle scienze umane. Eppure, se da un lato abbiamo dati che riportano un tasso di incidenza di malattie come la depressione e diverse forme d’ansia superiore rispetto alla normale popolazione, dall’altro abbiamo sondaggi che riportano risultati contraddittori per quanto riguarda la soddisfazione personale e il desiderio di rimanere nella ricerca.
In particolare, nel seguente studio su quasi 6000 dottorandi più di un quarto ha espresso preoccupazione sulla propria salute mentale, ma 80% di loro ha al contempo espresso un alto grado di soddisfazione con la propria scelta di lavorare nel mondo accademico.
Che tipo di interpretazione possiamo dare a questo risultato? Di certo è un tema molto complesso, ma a me sorge spontanea la domanda:
Quanto siamo disposti a sacrificare in termini della nostra salute psico-fisica? Quale prezzo siamo disposti a pagare per la gloria di un lavoro da ricercatori?
Io ho avuto la mia personale risposta durante l’ultimo anno di dottorato, nel momento in cui mi sono resa conto, grazie all’aiuto di un terapeuta, di stare sviluppando una forma patologica di ansia e depressione. Lavoravo cinque giorni a settimana in un laboratorio senza finestre, senza luce (necessario, perché lavoravo con sorgenti a singolo fotone) e per lo più completamente da sola.
Gli esperimenti non stavano andando bene, i risultati erano deludenti nonostante i miei sforzi e in più vedevo poca luce solare durante il giorno. Nel fine settimana non lavoravo, perché non ne ero in grado, ma passavo il tempo libero a preoccuparmi della tesi e degli esperimenti e ad augurarmi che succedesse qualcosa che potesse impedirmi di tornare in università.
Ogni volta che ho provato a comunicare il mio malessere, la risposta è stata qualcosa del tipo: ma è normale! Tutti i dottorandi si sentono così, non sei sola.
Nessuno si è mai indignato, nemmeno quando ho preso la decisione di iniziare ad usare dei blandi ansiolitici, che sono diventati indispensabili per farmi alzare ogni mattina per andare al lavoro, per partecipare ai meeting e svolgere le attività quotidiane. Avevo questa visione distorta per cui tutti intorno a me sembravano cavarsela meglio di quanto facessi io: ero l’unica a non avere ancora una pubblicazione al terzo anno ed ero ben lontana da ottenerne una. Mi stavo convincendo che ci fosse qualcosa di sbagliato in me, perché nonostante i miei sforzi non riuscivo a fare ciò che tutti si aspettavano dalla sottoscritta.
Ho preso in considerazione l’eventualità di mollare tutto, ma ogni volta mi prendeva la paura di rimanere senza un lavoro e con un programma di studi interrotto sul curriculum, una specie di marchio a fuoco.
Questi stessi timori mi hanno impedito di prendermi una pausa dagli studi, che pensavo davvero di non potermi permettere, perché se ci si ferma si ha fallito, si diventa dei perdenti, dei pezzetti di mondo improduttivo.
Insomma, dovevo tirare avanti e continuare a fare quello che stavo facendo anche se l’entusiasmo e la motivazione erano sottozero e la mia salute si stava deteriorando sempre di più.
Intanto venivo presa di mira da pubblicità tipo: “come pubblicare tre articoli al mese ed essere felici”, “come scrivere la propria tesi in dieci giorni”, “come costruire il proprio brand ed essere notati dai recruiter”, “come trovare lavoro senza fare duecento colloqui” e altro pattume informatico.
Insomma, oltre al danno la beffa: Internet mi stava facendo notare che non solo facevo fatica a completare un dottorato ma stavo anche per scoprire che nessuno mi avrebbe voluto assumere comunque perché il mio profilo LinkedIn è in uno stato pietoso.
Bene, andiamo davvero bene. Come è andata a finire questa storia?
Ciò che mi ha salvata è stata una fase di stallo nei miei esperimenti, per cui un giorno mi sono ritrovata con le mani in mano e niente da fare. Ciò mi ha portato verso uno stato di inattività e indolenza completi che è durato qualche mese, nei quali tutto ciò che ho fatto è stato guardare per aria: ero probabilmente l’essere meno produttivo del Regno.
Questo periodo di inattività e ozio è stato una vera benedizione, perché mi ha permesso di riflettere sulla mia vita e su quello che volevo. Ho capito che, dato che ormai la fine del dottorato era vicina, forse quello era il momento di cercare di capire cosa volessi fare dopo. Con molta onestà ho compreso di non voler assolutamente continuare una carriera nella ricerca e che avrei dovuto guardare altrove. La noia e la totale mancanza di aspettative date dalle circostanze mi hanno aiutata a guardarmi intorno e a capire davvero che tipo di vita voglio e che carriera mi sarebbe piaciuto iniziare.
Ho iniziato delle ricerche in diversi tipi di settori lavorativi che mi sarebbero potuti interessare e nel valutare le aziende ho cominciato a costruire un piano basato su metriche quali paga oraria, pause, presenza di orario di lavoro flessibile, trattamento dei dipendenti, insomma criteri ben diversi da quelli con cui avrei cercato lavoro tre anni prima. La tesi, la ricerca, gli esperimenti non conclusi hanno acquistato una dimensione nuova, meno drammatica e ciò mi ha dato un enorme senso di liberazione che mi ha permesso di agire con, paradossalmente, più lucidità.
Ho smesso di assumere ansiolitici o pillole per dormire, ho ricominciato a fare sport e a leggere, ho cominciato ad avvertire dentro di me un senso di entusiasmo per il futuro. Forse alcuni vedranno dietro a tutto questo un fallimento: fallimento di una carriera accademica, fallimento di una serie di convinzioni basate sul fatto che il duro lavoro mi avrebbe resa felice attraverso il “successo”. Io questo successo non l’ho visto, se per esso si intende non rimanere indietro e non fermarsi mai, ma questa facciata contro il muro mi ha fatta maturare e mi ha resa più consapevole.
In una società che ci impone l’infallibilità e la velocità la soluzione è ribellarsi e proporre un modello alternativo di individuo realizzato.
Un individuo che lavora duro, sì, ma sa anche quando e quanto fermarsi, che abbia consapevolezza di sé e che abbia una gestione equilibrata del rapporto tra la propria salute mentale e fisica.
Se non mi fossi fermata, se non avessi avuto un periodo di inattività in cui ero assolutamente improduttiva, non avrei avuto tempo di riflettere su cosa voglio davvero dalla vita e perché. Inoltre, è importante comprendere come non solo non sia necessario essere infallibili, ma che una rinuncia o un cambio di programma possano in realtà portarci sulla strada giusta per noi, magari verso una nuova opportunità, ad esempio la consapevolezza di voler cambiare carriera.
L’accettazione dei propri limiti, degli errori, delle rinunce e dei ritardi come punti di forza e non solo sorgenti di negatività è cruciale, così come è cruciale parlarne, far capire agli altri che non si è soli in un mondo di individui perfetti, bensì si è tanti individui imperfetti in un mondo altrettanto imperfetto.
È importante che la nostra generazione comprenda questo per cambiare e riformare la cultura del lavoro di domani e renderla più giusta e perché no, anche un po’ più autentica. Perché per ogni bambino di sette anni con una laurea in ingegneria nucleare ci sono molti che fanno fatica a dare esami e va bene così, la vita è fatta anche di frustrazioni e progetti mai conclusi.
Immagine di copertina:
Scuola di Atene. Foto da vatican.va
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.