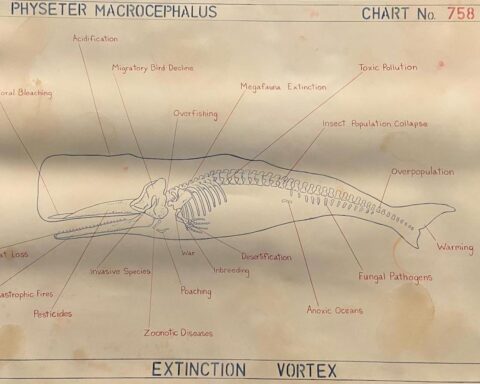Io sono confine. Tu sei confine? Siamo tutt* confini, in qualche misura. Con i nostri corpi, i nostri limiti più o meno esplicitati, le nostre linee di demarcazione, i nostri contorni più o meno sfumabili. Sarebbe bello pensarci e pensare tutto senza bordi: menti, corpi, terre, mari. Ma è possibile?
“Definire è limitare”, diceva qualcuno.
Ad animare riflessioni, può aiutare l’etimologia
La parola “confine” è molto affascinante. Spesso la associamo a concetti quali separazione, divisione, barriera, a verbi come superare, abbattere, aprire o chiudere, difendere o proteggere. Ma in realtà cum-finis è condividere un limite, è essere insieme presso una stessa “linea”; come esplicitato dal “cum” latino, mette in relazione l’io e il tu, il noi e il loro.
Non necessariamente ha a che vedere con il gioco di inclusione ed esclusione, di fuori e dentro. Il confine è anche qualcosa che sa di vicinanza, pur nella diversità.
D’altronde, “confinante” è qualcosa che sta a fianco, non rimanda a un’idea di distanza o di netta separazione. Se dicessimo: “io confino con te”? o “io ti sono confine”? Avremmo sempre la sensazione di alzare un muro, di scavalcare un rete di filo spinato? Ed è forse un caso che esista una stretta relazione etimologica tra la parola “confine” e la parola “affine” (ad-finis, sempre dal latino)?
Così il confine è sì delimitazione, ma al contempo avvicina il di qua e il di là, in un rapporto di reciprocità.
È interessante che per noi il termine abbia persino assunto un carattere legato a un’idea di isolamento totale all’interno di uno spazio (essere confinat*, confinamento), dove non esiste alcun incontro possibile, alcuna relazione con il resto, ma c’è solo un tu / io allontanat* da tutto.
Forse, il vero tema della mostra Io sono confine / I am border (Palazzo Grillo, Genova, fino all’8 aprile 2023), non è tanto quello estremamente attuale delle migrazioni – che pure impongono qui la loro urgenza – ma è proprio quello del “confine” nel titolo, nelle sue possibili declinazioni concettuali.
Andiamo con ordine
La mostra è appunto allestita presso gli spazi di un prestigioso palazzo storico di Genova, affacciato sulla caratteristica Piazza delle Vigne.
Voluto dal marchese Domenico Grillo nel 1545, Palazzo Grillo è stato impreziosito e ampliato nel corso degli anni. All’interno, affreschi e decorazioni marmoree animano le sale. Il prestigio dell’architettura è testimoniato dalla costante presenza dell’edificio negli elenchi dei Rolli tra il 1558 al 1664. Qua, insomma, soggiornavano le alte cariche in visita a Genova.
Il netto contrasto tra il privilegio manifesto di chi abitava lo spazio, anche solo per un breve periodo, e il “racconto” di diritti, viaggi, sogni, speranze e curiosità negati che sottende a molte delle opere ospitate, è un primo elemento di suggestione.
Il titolo della mostra, invece, si rifà a quello di un saggio di Shahram Khosravi pubblicato nel 2019.
La mostra
Una vera e propria ricerca etnografica condotta dall’antropologo iraniano per ragionare trasversalmente intorno ai concetti-chiave di migrazioni e flussi, frontiera, cittadinanza, nazioni, diritti, disuguaglianze, muovendosi tra etica, politica, geografia, antropologia, per smantellare e svelare retoriche, narrazioni parziali, pre-giudizi.
La collettiva muove dagli studi di Antonino Milotta, dottorando in Scienze Sociali presso l’Università degli Studi di Genova, con un progetto volto a individuare metodologie e pratiche artistiche che indagano il fenomeno della migrazione, ed è a cura di Pierre Dupont (Giulia De Giorgi, Michela Murialdo, Roberta Perego) e Anna Daneri.
La seconda opera che si incontra salendo le scale del percorso espositivo è un lavoro di Pamela Diamante, Comunicazione istituzionale 2016, un video-trailer che utilizza il linguaggio dell’ironia intelligente e i codici espressivi propri della comunicazione e delle campagne di sensibilizzazione per denunciare il paradosso del “mito” dell’umano che supera i confini spaziali.
Amadou, il protagonista astronauta del filmato, è un ragazzo africano – di dove esattamente, poco importa – più specificatamente un profugo (d’altronde, è abbastanza immediata la fastidiosa associazione africano-profugo), che ha potuto varcare i confini celesti e approdare su Marte.
Lì può essere confinato insieme ai suoi simili, risolvendo così il problema dell’ “invasione africana” del mondo civilizzato e, nel frattempo, soddisfare e perpetuare un’altra grande ossessione – o vizio – del potere occidentale: la colonizzazione di tutto ciò che garantisce sopravvivenza.
Centro di permanenza temporanea

In una delle prime sale, un frame cattura lo sguardo anche di coloro che frequentano il mondo dell’arte contemporanea da un po’, perché l’immagine, incredibilmente sempre attuale nel suo potere comunicativo, è diventata quasi iconica.
L’artista di origine albanese Adrian Paci ha realizzato Centro di permanenza temporanea nel 2007. La fotografia in mostra è estrapolata da un video di circa 5 minuti, ma da sola riesce a essere una efficace e immediata restituzione di sensazioni e condizioni umane: l’attesa, la speranza, la delusione, il sogno, il viaggio.
Quello che vediamo è un gruppo denso ed eterogeneo di persone migranti, nel senso più letterale e preciso del termine; di persone, cioè, che in gruppo si spostano da un luogo a un altro luogo.
Stanno andando nella stessa direzione? Siamo presso l’aeroporto di San Jose, California. Questi viaggiatori stanno partendo o rientrando? I loro volti sono quelli che la parte di mondo privilegiata legge come stranieri, ancora prima di conoscerne la storia.
Sembrano arresi, inermi, inerti, passivi, mentre intorno a loro la vita è sbloccata e altre ali, più fortunate, prendono il volo. La loro scala non porta da nessuna parte, l’aereo non arriva. Anche la loro scala sociale si è fermata.
Potrebbe anche narrarci, questa immagine, le fasi di una condizione esistenziale. Un passaggio temporaneo che prima o poi ci sfiora tutt*. Eppure, l’atmosfera suggerisce che questa loro “fase” sia una condanna permanente, una promessa di destino immobile, disegnato da un sistema esterno. Senza possibilità di fuga, ascesa, trasformazione.
Ho sempre trovato il titolo dell’opera perfetto, con l’accostamento delle parole “permanenza”, che indica un restare a lungo, e “temporaneo” che invece fa pensare all’instabilità della durata, alla provvisorietà.
Nero sangue
Una delle opere che ho preferito, nonostante la sua lettura quasi didascalica, è quella realizzata dalla giovane artista italo-senegalese Binta Diaw, Nero Sangue.
Un’installazione comprendente due pomodori vetrificati di nero e destinati alla naturale decomposizione, e un telo in cotone costellato di immagini e ritratti ripresi dalla rivista antisemita “La difesa della razza”, diffusa in Italia tra la fine degli anni ‘30 e i primi anni 40 per sostenere l’idea della superiorità razziale ariana, le leggi razziali e il colonialismo fascista.
Il titolo dell’opera rimanda immediatamente all’associazione tra il colore della pelle (simbolicamente, il nero) e il sangue, inteso come dolore, fatica, violenza.
Lo schiavismo sembra cosa lontana, e invece è ben noto quanto sia tutt’ora diffuso e quanto esperienze quali la raccolta di pomodori siano da ricondursi a fenomeni di caporalato che prevedono lo sfruttamento di lavoratori, in larga misura immigrati, pagati una miseria, privati di qualsiasi tutela.
I due pomodori diventano quindi un simbolo per tutti di potere e di dominio.
È curioso notare che la stessa coltivazione di pomodori è arrivata in Europa con il colonialismo, nel ‘500. A rafforzare la denuncia antirazzista e anticolonialista è il telo che completa l’installazione e sul quale sono riprodotte le immagini tratte dalla storica rivista.
E attenzione: non si trattava di un prodotto editoriale “di nicchia”, bensì di un quindicinale stampato e diffuso con cadenza regolare, strumento antisemita del regime fascista, destinato a promuovere le leggi razziali fasciste, controllato dal Ministero della cultura popolare e pensato per elaborare e divulgare una dottrina “scientifica” della razza che giustificasse e legittimasse agli occhi dell’opinione pubblica italiana la politica coloniale e, soprattutto, l’antisemitismo e il razzismo di stato.
Ora, se volete farvi del male (come me!) potete sfogliarla anche, la rivista: ogni singolo numero è stato digitalizzato ed è facilmente reperibile e fruibile online.
Sicuramente, quella di Diaw è una delle opere più esplicitamente politiche della mostra. Qua, il confine è mostrato nella sua accezione più inquietante e buia. È confine del pregiudizio razziale, della pelle, dei corpi, come barriera per escludere ma soprattutto per sottomettere, sfruttare, uccidere, invisibilizzare.
Sarebbe cosa distante, da guardare con lucido orrore, se non fosse che razzismo e neocolonialismo serpeggiano semi-indisturbati tra noi.
Strappo alla regola
Segnalo un altro lavoro, molto instagrammabile c’è da dire.
Parentesi senza la parentesi: l’instagrammabilità di un’opera è una qualità – positiva, negativa, dipende dai punti di vista – tutt’altro che secondaria nell’era digitale e della social-dipendenza.
È stato uno dei temi della mia terza tesi universitaria e continuo a considerare la questione rilevante. A proposito di confini, il digitale è per eccellenza lo spazio dell’illusione.
Sappiamo perfettamente, anche se tendiamo a dimenticarlo, quanto l’assenza di limiti e confini, online, sia mera apparenza. Inchiodate dall’algoritmo, dalla cerchia, dalla bolla dei dati. Non c’è alcun viaggio libero sullo schermo, confiniamo solo con chi cerchiamo, con chi vogliamo, con quello che desideriamo. Anzi, il desiderio è ormai in grado di anticiparci e cercare noi. Altro che libere migrazioni.
Sul web siamo tutti animali in uno zoo, osservati e osservatori attraverso le sbarre di un film sceneggiato ad hoc, con la perversa convinzione di abitare invece un’immensa foresta.
Comunque, chiusa la parentesi del web e della dimensione social, facevo riferimento al lavoro visivamente fortissimo di Serena Vestrucci, Strappo alla regola. (foto copertina)
L’ultima sala, che lo ospita, è, sul piano dell’allestimento, la più bella. L’intero soffitto è un cielo stellato come nella migliore tradizione pittorica. Ma in questo caso è un cielo politico, oltre che poetico. E non c’è la pittura.
Quanti cieli stellati abbiamo ammirato, dal vivo o sui libri? dall’antichissima tomba della regina egizia Nefertari alle volte blumare tempestate di stelle dorate di Giotto, e ovviamente Van Gogh, che trapunta la sua notte di astri malinconici.
Potevo farlo anch’io, capirai: tagliuzzare decine e decine di bandiere dell’Europa e ricomporle liberamente. Una “piccola” operazione che vale un intero slittamento di significato. Potevamo farlo, ma ci ha pensato Vestrucci. Il risultato è una costellazione inedita, sciolta e dinamica.
Innanzitutto, l’Europa per come la conosciamo nei suoi confini geopolitici e valoriali non esiste più. Le stelle sono liberate, la regola è strappata.
Se c’è un oggetto-simbolo che mi mette spesso a disagio è la bandiera, specie quando manifesta un’appartenenza di tipo nazionalista. Rubo una frase letta proprio sulla bacheca Facebook di Khosravi, giunto a Genova per l’incontro di riflessione intorno alla mostra che appunto riprende il titolo del suo saggio:
una città appare più civilizzata stendendo i panni alle finestre che non appendendo bandiere
SHAHRAM KHOSRAVI
Ecco, diciamo che sono d’accordo. Nel lavoro di Vestrucci il cerchio-potere è scomposto, l’unità degli stati membri è persa, in teoria. C’è da dire che in termini di politiche migratorie quel cerchio unitario è davvero solo simbolo e pochi fatti.
Eppure, a guardare quel cielo ricucito fantasiosamente, la sensazione è che l’armonia sia invece rafforzata. Il cerchio è unità ma è anche figura chiusa e statica, è border, è limite, contorno, confine tra un dentro e un fuori che non può accedere. E infatti lasciamo morire le persone a pochi metri dalle coste delle nostre estati di vacanza.
Che l’Europa non sarà compatta nell’accoglienza, ma certo, a misure variabili, lo è in termini di scelte o non scelte disumane, disumanizzanti.
In Strappo alla regola le stelle diventano tantissime, si moltiplicano, promettendo infinite ricomposizioni e pluralità. Le bandiere hanno tra loro leggere variazioni di colore, la ricchezza della diversità. Le cuciture si devono vedere. Cucire è un gesto bellissimo, paziente, che tiene insieme, ripara, crea.
Alla fine, è il contrario di strappare.
Voglio parlare di altri due lavori
Giuseppe Mirigliano, artista che apprezzo molto, ha presentato un’opera realizzata nel 2017, INVOLOINTERRA, parte di una serie di altri lavori nei quali la sospensione fa da padrona, con il posizionamento sulla bianca parete di piccole parti di miniature dipinte a olio su carta, apparentemente cocci, disposti disordinatamente.
Qua il confine della forma è del tutto superato in virtù della disgregazione, della distruzione e della ricomposizione.
Il campo generato da Mirigliano è aperto, sospeso, esprime un senso di lirica fragilità che si accompagna però a un calmante senso di energia essenziale. C’è la forza, anche, che risponde alla ricerca improvvisamente inutile di un equilibrio tra le parti, di una costruzione unitaria e ordinata. Il caos appare così incredibilmente rassicurante. Lo scarto, la marginalità, i “cocci”, appunto, assumono una loro integra e profonda dignità e unicità.
È un messaggio di rinascita, di delicatezza che è insieme anche potenza.
E ora, usciamo dal palazzo. Menziono un altro lavoro – sarebbe meglio definirlo progetto – che si trova a presidiare la soglia, il confine tra interno ed esterno, sorta di benvenuto o arrivederci, augurio o dedica o monito o preghiera. Quasi un manifesto, difficile da leggere nonostante le grandi dimensioni. Ma la difficoltà di visione potrebbe essere una scelta calcolata.
Ho conosciuto l’artista Jonida Xherri indossando un suo splendido lavoro, avvolgendomi con il risultato di ore di incontri e relazione tessute. Questa volta osservo dal basso-lontano il suo messaggio. Per leggere tutto, bisogna allontanarsi. Una pratica che sarebbe bene esercitare, anche se spesso quanto più ci avviciniamo, tanto meno troviamo il senso logico della barriera e del pregiudizio.
Si tratta di O Italia, o grande stivale, non cacciarmi di nuovo a pedate, un arazzo lungo dieci metri che per qualcun* potrebbe inaugurare e per altr* concludere il percorso.
La frase che leggiamo tra mille colori è una citazione di Emanuel Carnevali, poeta e migrante italiano di ritorno dall’America nei primi del ‘900. Il lavoro stesso di Xherri è un lavoro migrante che l’accompagna qua è là per il paese. Contrariamente a una bandiera che rimarca l’appartenenza a uno stato o a un credo, questo è un messaggio universale che trova nella sua dimensione aperta al pubblico continui possibili significati. Forse per questo sta fuori, guarda e si lascia guardare dalla piazza, senza obbligare al varco, all’entrata.
L’opera è stata esposta anche a Lampedusa sulla facciata del Museo della Fiducia e del Dialogo nel Mediterraneo ed è quella che si dice un’opera partecipata perché Xherri ha voluto che tra le sue trame si intrecciassero storie, persone, esperienze, dita operose. Certo val la pena pensare che questo arazzo di vite e messaggi abbia viaggiato più liberamente di tante persone.
Alla fine, quella di Xherri è una comunicazione a chi vuole andar via e a chi vuole restare, ma solo a condizione di vedere e vivere un’Italia migliore di questa, dove il senso di appartenenza o di identità non debba necessariamente riconoscersi nella prigionia del confine-nazionalista che scaccia la diversità e ripudia la mescolanza.
Della mostra, in generale, ho apprezzato l’eleganza, la mediazione artistica rispetto alla crudezza della cronaca
Evitare l’immagine feticista, pornografica, a tratti perversa che inonda le nostre visioni per poi anestetizzare le nostre reazioni, abituarci all’orrore, uccidere la sorpresa ma ancor di più la profonda riflessione, è esercizio difficile.
L’arte può raccontare le complessità, i processi, le radici, anche il dolore, certo, ma restituendo la cornice, lo spazio e il respiro, la dignità e il rispetto. Non sempre gridare è il migliore strumento per farsi sentire, nel pianeta delle immagini e degli immaginari preconfezionati.
La cronaca ci mostra la coperta termica dell’emergenza e del soccorso, ma Ryts Monet la trasforma in Carpet, in un tappeto dall’aria preziosa, non calpestabile. Anche perché su essa compare un motivo ripreso da decorazioni tradizionali mediorientali.
Qua è un tentativo di recuperare l’identità negata quando uniformemente facciamo la conta, accavalliamo numeri, perdiamo i volti, le lingue, le culture. Dimentichiamo le persone, dentro la narrazione populista, sia essa di destra o di sinistra.
Durante il percorso espositivo confini materiali e immateriali si snocciolano davanti a noi, senza costringerci alla realtà cruda e non mediata cui siamo continuamente sottopost*, in un vortice di bulimico voyeurismo.
Altra nota apprezzabile è la dimensione multimediale, con una larga presenza di filmati che meritano la visione e chiedono lentezza, tempo.
Le parole finali di questa riflessione voglio riservarle all’incontro tenutosi il 25 marzo presso LaClaque con Shahram Khosravi, professore di Antropologia sociale all’Università di Stoccolma, saggista ed ex-migrante illegale, e Sandro Mezzadra, docente di Filosofia politica all’Università degli Studi di Bologna.
Una conversazione stimolante, dove si è parlato, tra le altre cose, della complessa distinzione tra migrazione forzata e volontaria, dei limiti di una visione eurocentrica, occidentale e privilegiata per leggere e interpretare i fenomeni, della necessaria distinzione tra scafisti e mercanti di vite, di mercato delle armi, di legalità e illegalità dei corpi, del ruolo colpevole del sistema-Europa, del migrante come eterno straniero (stranger, strano) anche quando stabilizzato, bloccato in una condizione che è perfino trasmissibile di generazione in generazione.
Si è parlato di tempo: la migrazione, infatti, non è solo fenomeno spaziale, ma anche temporale.
L’antropologo ha raccontato di aver conosciuto chi ha impiegato quindici anni a coprire una distanza geografica che per molte delle persone presenti in sala significa probabilmente qualche ore di aereo. In tal senso l’opera citata di Paci è potentissima perché sa restituire proprio questa doppia dimensione del confine, inteso nella sua ottica spaziale e temporale insieme.
Mi fermo, per lasciare spazio alla scoperta.
Il consiglio, comunque, è semplice e diretto: visitate la mostra nei suoi ultimi giorni, se potete. E per una preziosa panoramica su ciò che attende, leggete il bel pezzo dell’amica e collega Virginia Lupo: Io sono Confine. Una mostra sulle frontiere e le persone che le attraversano.
Buon viaggio, almeno voi.
Immagine di copertina:
“Strappo alla regola” di Serena Vestrucci. Foto di Amina A.
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.