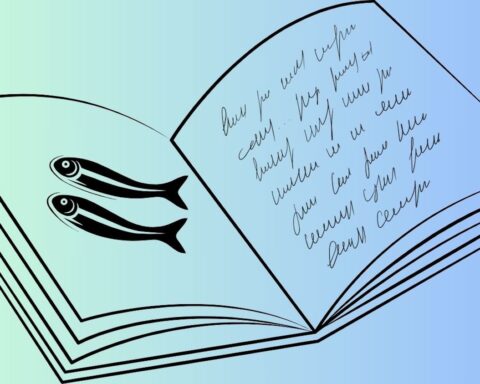Scrivo questo pezzo rinchiusa nella mia casetta. Sono al decimo giorno di clausura a seguito di positività al Covid-19. Triplo-vaccinata. Asintomatica. Le mie giornate di mutua trascorrono lente tra studio, giochi da tavola, binge watching di “The Office” e cucina.
Sto cucinando di brutto, sento di potermi definire serenamente ninja di panificazione e master di crostate.
Quali strascichi mi sta lasciando il covid? Un leggero sovrappeso.
Mannaggia a me e alla mia fame.
Saranno le mutazioni, saranno i vaccini, sarà la mia giovane età, ma oggi il mio timore più grande è quello di perdere temporaneamente il gusto. O ancor peggio, perderlo a lungo termine e vivere in un limbo di pietanze insapori e tutte tristemente piatte.
Ma il gusto da cosa deriva? Come mai è così strettamente personale?
Quante volte a cena fuori con amici è capitato di sentir pronunciare frasi come “No, io il piccante non lo sopporto proprio.”, “Indiano? Troppo speziato per me…”, “Ma come fai a bere il caffè amaro!”.
Che cosa detta le nostre scelte culinarie? Prediligere certi alimenti anziché altri è frutto di capricci personali oppure c’è qualcosa di più dietro? E se c’entrasse la genetica?
Ma procediamo con ordine. Tra i cinque sensi, il gusto è quello che nei secoli ha permesso all’uomo di riconoscere gli alimenti commestibili ed evitare quelli contenenti sostanze potenzialmente pericolose per l’ingestione, e in qualche modo ci ha permesso di arrivare fino a oggi.
All’interno della bocca, localizzati in differenti punti della lingua, sono presenti dei bottoni gustativi che ci permettono di distinguere cinque qualità di gusto:
amaro, acido, dolce, salato, e umami. Recentemente sono stati scoperti inoltre dei recettori per il gusto del grasso.
L’amaro identifica sostanze tossiche, l’acido protegge dagli alimenti avariati, il dolce indica i cibi più nutrienti, il salato individua il sodio e altri cationi (sali minerali), l’umami, infine, denota la presenza del glutammato – il sapore tipico del brodo di carne, del parmigiano o dei funghi, per capirci.
Se la distinzione tra dolce e amaro ha salvato i nostri antenati da molecole potenzialmente dannose, guidandoli verso i nutrienti corretti, oggi, per fortuna, il gusto cessa di essere un metodo di sopravvivenza. Resta però un senso estremamente personale che guida abitudini alimentari e tradizioni culinarie.
Tra i cinque gusti, quello che più divide è certamente l’amaro
La sua percezione, infatti, varia da individuo a individuo, frutto forse di un retaggio evolutivo. La ricerca sul gusto dell’amaro è iniziata nel 1931, a partire da un evento casuale, come spesso accade nella scienza.
Arthur Fox, inglese, per errore rilasciò nell’aria del suo laboratorio una nube di cristalli fini di Feniltiocarbamide (PTC). Lui non si accorse dell’emissione, ma i colleghi avvertirono immediatamente una sostanza amara nell’aria. Il ricercatore, incuriosito da quanto accaduto, iniziò a testare parenti e amici per tentare di spiegare il fenomeno.
Da lì seguirono diversi studi che dimostrarono come la capacità di percepire il PTC (e successivamente anche il propiltiouracile, PROP) variasse da individuo a individuo, in forme più o meno intense.
Ma la causa della percezione dell’amaro è stata identificata solamente nel 2003: una piccola differenza sul cromosoma 7 codifica per un recettore chiamato TAS2R38.
Facendo una breve parentesi esplicativa (non me ne vogliano genetisti e biologi se la faccio troppo facile), la proteina prodotta dal gene TAS2R38 può contenere due sequenze: Alanina-Valina-Isoleucina (AVI) oppure Prolina-Alanina-Valina (PAV). Il modo in cui le due si combinano tra loro ci permette di stilare tre classi sulla base del diverso grado in cui questo gusto si manifesta agli individui: AVI/AVI “non tasters”, PAV/AVI “tasters” e PAV/PAV “super tasters”.
Si stima che il 30% della popolazione sia insensibile al gusto amaro, ossia “non taster”; il 50% lo percepisce moderatamente, “taster”; il restante 20%, la fetta più interessante, è estremamente sensibile, “super taster”.
Per questa ultima classe, non solo l’amaro risulta inavvicinabile, ma anche tutti gli altri sapori sono percepiti in maniera amplificata. Per esempio il piccante e il grasso sono avvertiti in modo differente rispetto al resto della popolazione. Per i “super tasters”, dunque, niente caffè, cacao, chinino, vino rosso e alcolici in generale, naringina (contenuta nei pompelmi), crucifere.
Il fatto interessante è che questa differente capacità percettiva è un carattere trasmissibile da genitori a figli.
Ampliando il quadro, troviamo che la distribuzione della popolazione nelle tre classi assume un aspetto di tipo geografico. Da studi, emerge infatti come i “non tasters” siano scarsi in Giappone, Cina e Africa Nord-occidentale, e ciò potrebbe spiegare pietanze più delicate e amabili, mentre siano di gran lunga superiori in India, dove per l’appunto la cucina è un tripudio di spezie.
E allora viene da chiedersi se lo sviluppo delle nostre tradizioni culinarie sia scaturito dal susseguirsi della storia o se anche la genetica vi abbia messo il proprio zampino.
Se, come sembra, la biologia ha guidato le nostre preferenze in fatto di cibo, anche le varietà delle coltivazioni in diverse aree geografiche, lo sviluppo di alcuni prodotti a scapito di altri, potrebbe aver subito questo tipo di influenza. Non solo certi alimenti hanno superato la selezione perché più resistenti a dati climi, ma anche perché, magari, più conformi al gusto della maggior parte della popolazione di un’area specifica.
Concludendo, prova a fare un rapido sondaggio tra i tuoi amici: sottoponi loro i cibi tipicamente amari elencati sopra e osserva la reazione. Se il solo odore li disturba, se all’assaggio strizzano gli occhi e si rifiutano di continuare, be’, complimenti! Hai identificato dei super tasters!
E tu? Di che gusto sei?
Immagine di copertina:
Foto di Alexander Stein
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.