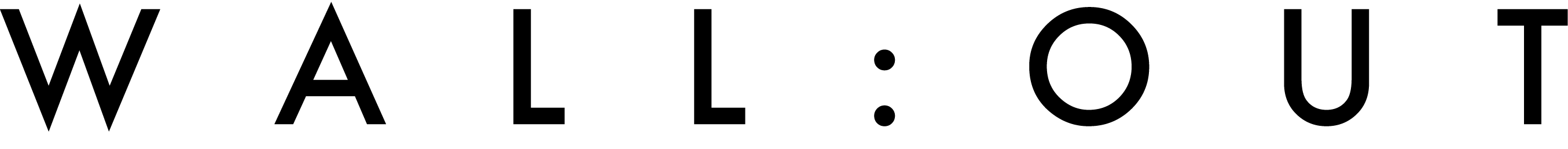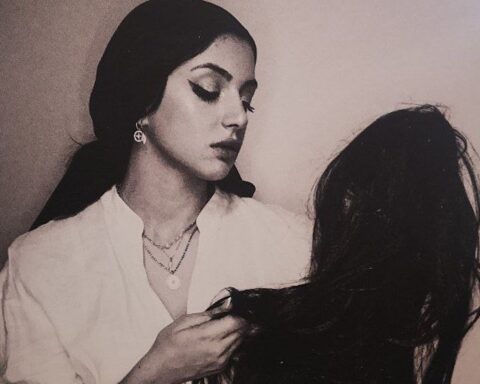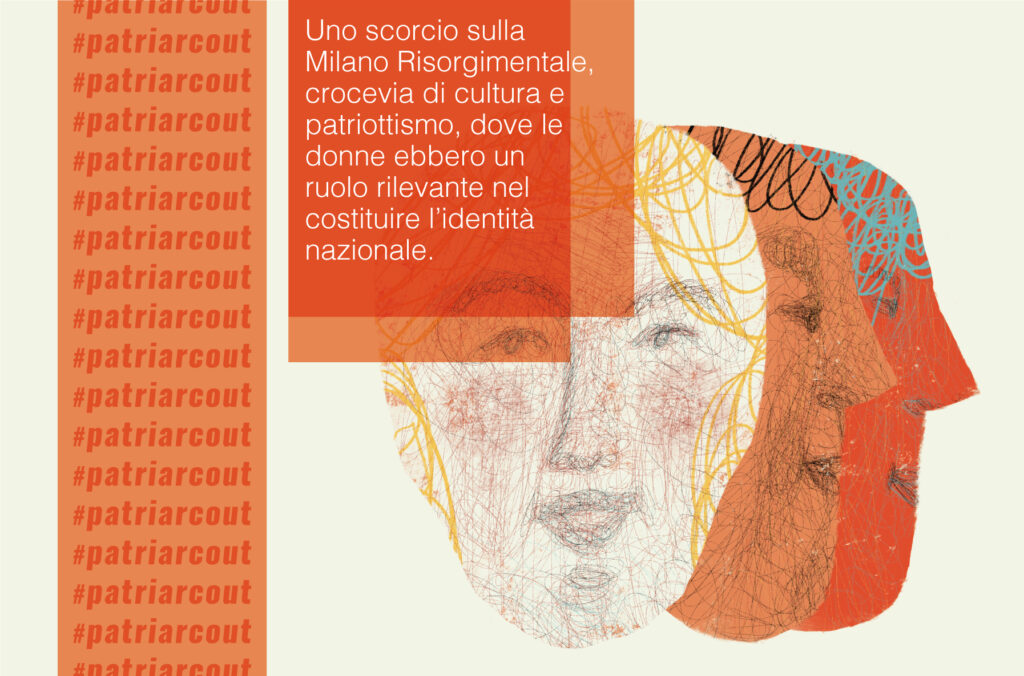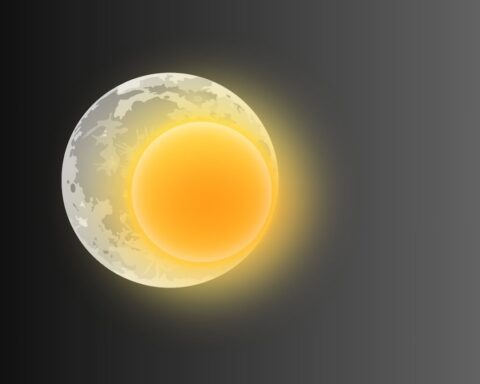È in una notte di inizio maggio a La Paz, in Bolivia, in cui, animata dal vago desiderio di cambiare vita dopo anni di lavoro e di tornare a studiare ciò che mi appassiona, mi diletto in una randomica ricerca su internet di corsi di laurea che affrontino gli studi di genere con un forte taglio socio-economico.
È così che mi imbatto nel master in Gender, Politics and International Relations offerto dall’University College of Dublin (UCD), ed è amore a prima vista.
Forse inizialmente un po’ per gioco, faccio domanda, vengo accettata, e tre mesi dopo atterro a Dublino per iniziare questa nuova avventura, in un misto di frenetica eccitazione e terrore dell’incerto.
Il master
Il master (che corrisponde a una laurea specialistica in Italia) è condotto all’interno della Scuola di Scienze Politiche e Relazioni Internazionali (SPIRE).
Ampissima scelta è lasciata allə studentə riguardo lo specifico curriculum: quattro sono i corsi obbligatori più altrettanti elettivi, all’interno di una gamma che spazia dagli studi più tradizionali di scienze politiche e relazioni internazionali, a moduli interamente organizzati intorno agli studi di genere, che coprono l’intera gamma delle scienze sociali (e non solo quelle):
dalla Teoria del Femminismo a studi di Genere e Politica, Sviluppo Economico, Pace e Sicurezza, Giustizia, Politiche Pubbliche e Ineguaglianza.
Per me, la gioia più acuta è stata scoprire che il femminismo si può fare anche a scuola, può costituire una lente scientifica con cui guardare alla realtà, può diventare una professione.
A questo riguardo, è necessario precisare che gli studi di genere non sono (ahimè) necessariamente femministi, e non necessariamente si occupano, o dovrebbero occuparsi, di un approccio binario eteronormato “maschi contro femmine”.
Gender
La parola ‘gender’, così temuta dal Vaticano e dalle destre, strumentalizzata con un’accezione inesistente per puri scopi propagandistici, è un termine molto complesso e dibattuto tutt’oggi, che contiene al suo interno la dimensione della discriminazione, delle gerarchie, del potere: si sostanzia nella constatazione di ineguaglianze ed emarginazioni umane, sociali, economiche, fondate su attributi percepiti come biologici (il cosiddetto ‘sesso alla nascita’) e ‘naturali’ (l’inclinazione ed i gusti sessuo-affettivi).
Diverse correnti di pensiero si sono dedicate allo studio del genere ben oltre a queste dimensioni, definendolo come un costrutto puramente sociale, nel quale ogni essere umano viene incasellato, cresciuto, educato e indirizzato, contribuendo così alla definizione delle sue caratteristiche che spesso percepiamo come genetiche, elettive, derivanti dalla nostra biologia.
Si tratta in realtà di modelli comportamentali ed emotivi che seguono le linee a volte invisibili del concetto dualistico di mascolinità e femminilità, ognuno dei quali ha delle norme ben definite.
Infatti, secondo una corrente femminista di cui Judith Butler è guida, il genere non solo è attribuito ma viene anche costantemente performato, in livelli e gradi diversi a seconda del contesto sociale (pensiamo ad esempio al maschio etero bianco cis che performa il ruolo del comandante militare nella vita pubblica e del padre amorevole nella vita privata).
Questo concetto ha due importanti conseguenze:
La prima è che non solo suggerisce (impone) determinate caratteristiche sociali a diverse categorie di persone, ma crea anche una gerarchia concettuale e materiale tra le due: maschile, maschio, forza, intelletto, razionalità, potere, come attributi superiori, più desiderabili; femminile, femmina, debolezza, sensibilità, emotività, dominazione come qualità intrinsecamente inferiori.
La seconda grande conseguenza risiede poi nel fatto che coloro che non aderiscono al modello maschile/femminile che i loro attributi sessuali suggerirebbero, a loro volta perdono status sociale e soffrono diversi livelli di emarginazione: dalle persone etero cis che non si conformano agli standard, alle persone queer.
Questi differenti livelli discriminatori creano una piramide sociale in cui al suo apice risiede il cosiddetto maschio alfa, ma anche e soprattutto in cui coloro che ‘mancano’ di una qualche forma privilegio, a loro volta perpetuano forme di emarginazione nei confronti di coloro che risiedono, nella gerarchia, a livelli inferiori.
Finisce qui?
Purtroppo no, perché i femminismi post-coloniali e intersezionali mettono in luce che questo tipo di gerarchia si sovrappone e opera in sinergia con altre forme discriminatorie basate su razza, etnia, classe sociale, conformità fisica (abilismo, magrezza, età), andando a comporre quella che è stata definita la “ruota del privilegio”.
Il corso di laurea in Gender, Politics and International relations affronta tanti di questi temi legandoli alla realtà politica, economica e sociale in cui viviamo:
dalla violenza di genere al gender pay gap come fenomeni globali, alla scarsa rappresentazione pubblica delle minoranze (così come descritte dalla ruota del privilegio) in politica, al nesso evidente tra passato postcoloniale e sistemi di sfruttamento ed emarginazione, alle preoccupanti ribalte conservatrici delle ultra destre in tutto il mondo e alla loro sempre maggiore somiglianza a regimi totalitari e sessisti un tempo strumentalizzati come baluardi per inesistenti lotte di civiltà.
Si parla del ruolo delle istituzioni internazionali nel creare e supportare la giustizia di genere e dei loro fallimenti, delle lotte della società civile per i diritti umani, dell’insidiosa e costante presenza del sistema capitalistico nel rinforzare e mascherare l’ineguaglianza dietro pratiche di pink o rainbow washing; delle guerre e dei sistemi che le nutrono con la retorica del nazionalismo machista, con i suoi effetti ancora più devastanti, ancorché invisibilizzati, su certe categorie umane.
Si parla di femminismi (perché sì, sono tantissimi), delle loro sinergie e dei loro conflitti; di cosa significhi vivere la discriminazione e su quali strumenti adottare per resistere ed agire all’interno di contesti in cui gli strumenti a disposizione possono essere limitati, senza dovere necessariamente ricadere nella categoria delle vittime.
Perché quando parliamo di discriminazione sia chiaro che ci si riferisce non solo a emarginazione sociale ed emotiva, ma anche economica, fisica, politica, in definitiva umana.
Immagine di copertina:
Grafica wall:out magazine su illustrazione di Rebecca Fritsche
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.