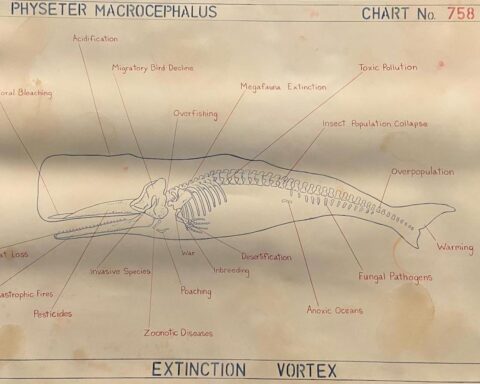Arianna Carossa (Genova, 1973) ha fatto della convivenza degli opposti una metodologia di ricerca e uno stile di vita:
“è con la pratica [artistica n.d.a.] che ho scoperto diverse facce di me stessa: in me convivono contemporaneamente un’Arianna meditativa, che ha bisogno di calma e raccoglimento per entrare in profondità delle cose, e un’Arianna decisamente sociale, che adora le feste e che cerca nelle relazioni quel dato imperscrutabile che ci rende umani.”
L’opera d’arte è quindi il mezzo per coltivare una concezione più sincera della sua vita, procedere verso uno stadio di comprensione più autentico, e uno strumento per stabilire relazioni con il contesto, con altre persone.
Sembra non avere mai avuto dubbi sulla sua volontà di dedicarsi alle arti, visto che a quindici anni già scriveva a Leo Castelli a New York di voler lavorare con lui. Non stupisce che Genova le sia stata stretta.
Dopo il diploma in pittura all’Accademia Ligustica di Belle Arti, ha iniziato ad esporre a Milano presso lo Studio d’arte Cannaviello, che aveva trovato interessante sfogliando le riviste di settore che le permettevano di scoprire cosa succedesse al di là dei Giovi. Eppure l’eccitazione del sistema, le continue mostre, l’impostazione concorrenziale rispetto allɜ altrɜ artistɜ, la sensazione di essere inerme nei confronti del mondo delle gallerie, l’hanno spinta a lasciare da parte i pennelli per dedicarsi solitaria a una produzione più concreta e oggettuale.
È stato questo cambio di prospettiva che le ha permesso di vedere il lavoro artistico non più come fine, ma come mezzo. E a questa filosofia si attiene ancora.
“Quelle sono le cose che mi piacciono di più e quelle in cui mi diverto di più, perché ho proprio l’attitudine a creare una relazione. La cosa che mi piace di più di tutta questa faccenda dell’arte che mi è capitata addosso è trovare una relazione con le cose, gli esseri umani.”
La relazione primaria dell’attività di Carossa è, senza dubbio, quella con il suo ambiente, il suo studio.
Negli ultimi quattro anni, ha avuto in sorte di insediarsi al Metropolitan Building a Long Island City, in un edificio che sembra più un castello che un grattacielo, adibito nel tempo a location per eventi privati e set fotografico e cinematografico (per fare qualche esempio, numerosi servizi di Vogue sono stati scattati al suo interno, così come alcune scene di Matrix).
La sua capacità di attirare incontri fortuiti estremamente fecondi si è manifestata anche nel caso della fu proprietaria dello stabile, la signora Eleanor Ambos – la quale professava una vera e propria passione per gli spazi abbandonati di New York ed era riuscita a costruirsi un impero personale fatto di palazzi fatiscenti acquistati per il puro gusto di trasformarli e riarredarli – conosciuta grazie a un comune amico, il pornografo Michele Capozzi.
Sopravvenuto il decesso della proprietaria e in seguito alla decisione dellɜ eredi di rimettere l’edificio sul mercato immobiliare, Arianna Carossa ha deciso di sfruttare il momento di stasi dovuto alla pandemia per dare la sua ultima mostra nello studio, prima di doverlo abbandonare definitivamente, riscoprendone così la versatilità di spazio espositivo, invero poco esplorata (“Avrei dovuto farci più feste!”, sospira ripensandoci) durante la sua permanenza.
La documentazione fotografica dell’evento arriva alle testate di settore a finissage già avvenuto, con lo sgomento di conoscenti e appassionatɜ che non avendo ricevuto la notizia per tempo non hanno potuto parteciparvi.
Il parallelismo con gli altri eventi tenutisi al Metropolitan Building, come i matrimoni e le feste di cui rimane traccia sul sito dell’edificio, non è immediato, cionondimeno coglie con puntualità feroce una delle più evidenti storture del sistema dell’arte contemporanea: “In the trees” – questo il titolo della mostra – esiste per il pubblico e per la comunità artistica di riferimento solo in quanto residuo documentale del suo allestimento.
Questa operazione, che svuota il glamour della partecipazione ossessiva alle vernici in gallerie e studi d’artista, più attente all’instagrammabilità dellɜ invitatɜ che alla comunicazione delle pratiche artistiche, fa da contraltare a un progetto di qualche anno addietro di Carossa, ossia “The Aesthetic of my Disappearance” (Printed Matter, 2014).
L’idea alla base di questa pubblicazione era estirpare ciò che lei chiama “il capitalismo delle immagini” della società moderna, mettendo al tempo stesso in discussione la centralità del testo critico rispetto all’oggetto d’arte tramite una serie di nove conversazioni con curatorɜ italianɜ e internazionali in merito a nove mostre esistenti solo nella sua immaginazione, o in quella dellɜ suɜ interlocutorɜ.
In definitiva, l’imprescindibile è e rimane l’opera d’arte in tutta la sua concretezza.
L’esplorazione di Arianna Carossa con e nella materia va sempre in direzione di quella composizione di opposti che incorpora la sua idea di arte. Organico e inorganico, umano, animale e vegetale, sono i cardini della produzione scultorea dalla quale scaturisce potente una dimensione relazionale attiva, divertita, leggibile su più registri.
Colpisce al primo colpo d’occhio la curiosità dell’utilizzo di parti animali come carapaci, corna, pelli, tutto ciò che deriva naturalmente da una muta e che va a combinarsi con materiali quali legno o bronzo in un gioco costante di rimandi tra l’animato e l’inanimato, la presenza e l’assenza, il pieno, il vuoto, dietro il suggerimento di una presenza umana che deve mettersi in ascolto e trovare a sua volta una relazione con la complessità dell’opera.
L’eleganza formale – fissazione molto italiana, sottolinea l’artista – non è necessariamente nel suo radar, anzi spesso, nel suo caso, è la rudezza dell’estetica ad aumentare la forza del messaggio.
Racconta che le è capitato di affrontare l’argomento una serata presso il consolato italiano a New York, dove l’unica persona che ha concordato con lei è stata Isabella Rossellini, la quale in seguito è diventata sua fornitrice di cera d’api.
“In the trees”, realizzata in collaborazione con il sound designer Marc Urselli e il pittore e allestitore Adriano Valeri, a cura di Ana Sofia Mesenes e Luca Bochicchio, in quanto esposizione del materiale di studio, sta cercando una nuova collocazione e una soluzione potrebbe essere quella di ricreare l’esperienza del Metropolitan Building in altre sette luoghi, a partire dall’attigua American Irish Historical Society.
Si diceva poc’anzi della sbalorditiva capacità nelle pubbliche relazioni di Carossa, che l’ha portata nel tempo a lavorare con aziende del calibro di Eataly e Kartell, circostanza che mediamente in Italia viene interpretata come uno svendersi al sistema produttivo e – orrore! – una profanazione dell’Arte.
Al netto del fatto che le gallerie specializzate non adottino logiche economiche diverse rispetto alle aziende, può accadere che queste ultime lascino più libertà allɜ artistɜ, senza schiacciarlɜ (o facendolo meno), rendendo la collaborazione più stimolante. O perlomeno, è stato così per Carossa:
“Generalmente, in quanto artista, io prediligo un atteggiamento trasversale: è sempre complicato trovare l’equilibrio tra la produzione artistica fine a se stessa e l’attività di relazioni, di organizzazione pratica dei progetti, di comunicazioni… del managing, in poche parole. Un po’ di fatica in più in questo senso, e la testa sulle spalle, ti permettono di svincolarti dalle maglie asfissianti del sistema delle gallerie, e trovare scappatoie nuove, divertenti, irriverenti.”
Sebbene con modalità diverse, sia in Italia sia negli Stati Uniti il settore galleristico non supporta davvero lɜ artistɜ, relegandolɜ in posizioni contrattuali svantaggiose e promuovendo un modello di lavoro che si avvicina pericolosamente all’autosfruttamento, salvo rari casi eccezionali.
Da questo punto di vista, Carossa considera più importante l’istituzione del museo, che si occupa di registrare quanto stia avvenendo nel mondo dell’arte contemporanea e dovrebbe garantire maggiore spazio per la sperimentazione. Ovviamente, i musei italiani fanno fatica a reggere il confronto con gli altri paesi europei (Germania e Francia in primis), mentre quelli statunitensi si trovano sempre più condizionati dalle pressioni delle gallerie.
Per quanto viziato dal suo stesso sistema economico senza controlli, il mondo dell’arte contemporanea negli USA ha dalla sua parte il riconoscimento dell’artista come lavoratorə a tutti gli effetti.
Per spiegare la diversa considerazione che hanno lɜ artistɜ tra Italia e Stati Uniti, Carossa fa riferimento alla sua esperienza con la pandemia nel 2020.
Prima che Trump decidesse di chiudere le frontiere, quando è riuscita per un soffio a rimpatriare, il Italia il durissimo lockdown imposto dallo Stato permetteva di uscire di casa solo a chi ne avesse strettamente necessità; ecco che i documenti italiani non le davano garanzia di potersi procurare i materiali per la produzione delle sue opere, tanto che, per andare ad acquistare dei colori per dipingere, si sentiva più tranquilla a portare con sé il passaporto internazionale, dove a chiare lettere è scritto ciò che la carta d’identità non riconosce, ovvero che il suo mestiere è l’artista.
Anche al di là di un effettivo mancato riconoscimento da parte della società in senso lato, il sistema dell’arte stesso dimostra di non conferire allɜ artistɜ il ruolo centrale che, a ben vedere, dovrebbero rivestire.
È così, conferma Carossa, che scrivere a un’istituzione museale o a una galleria nel Bel Paese si rivela la maggior parte delle volte un esercizio vano, mentre chiunque negli Stati Uniti riceve risposta, per via di una forma di rispetto del lavoro che non ha traduzione da noi.
Per quanto divincolarsi dal sistema sia un’utopia poco fruttuosa, il consiglio di Carossa a coloro stiano intraprendendo la carriera di artistɜ è di non fossilizzarsi nel trovare il proprio spazio come membri della scuderia di una galleria, quanto piuttosto trovare la propria voce e diventare megafoni di se stessɜ. Senza per questo diventare autoimprenditorɜ, tessere le proprie relazioni e farle fruttare attraverso la produzione artistica rende il lavoro più libero, più coraggioso e più autentico.
Una felice paronimia inglese recita: “The world is your lobster”, ossia “il mondo è la tua aragosta”, anziché la tua ostrica. Chissà che per Arianna Carossa non sia più vero così.
Articolo di:
Arianna M. e Corinna T.
Immagine di copertina:
Mostra “In the trees”. Courtesy of Arianna Carossa
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.