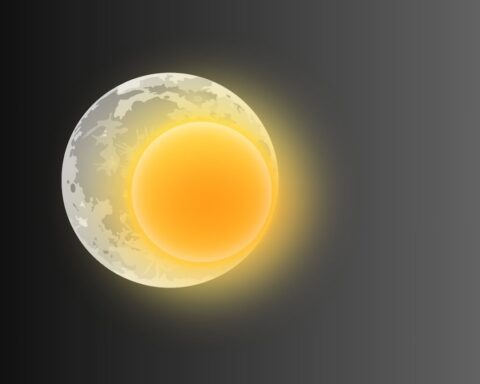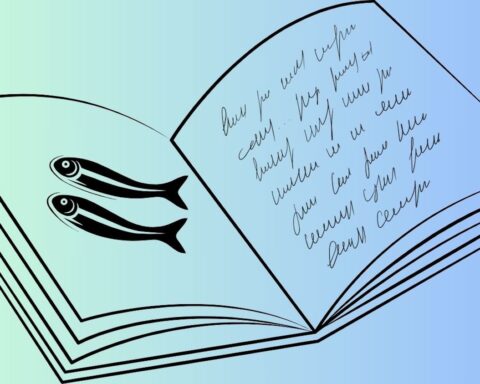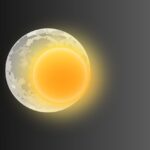Non passa 25 novembre in cui non si assista a una carrellata di iniziative più o meno intenzionate, più o meno autopromozionali, per sensibilizzare al fenomeno della violenza sulle donne.
Ciò a cui spesso tuttavia questa sensibilizzazione, per lo meno nel discorso pubblico, si riduce è una condivisione di dati tratti dalla cronaca e di racconti che confermano una certa immagine consolidata della violenza di genere, bollandola insieme come diffusa eppure eccezionale, come un’emergenza e una fatalità.
Di rado, invece, ci si interroga su quali siano le cause di questo fenomeno, al di là delle circostanze che accompagnano le dolorose, spesso tragiche, storie individuali.
Per comprendere meglio le ragioni sistemiche della violenza, ciò che permette continui a sussistere, abbiamo chiesto ad Alessia Dulbecco, pedagogista, formatrice e counsellor specializzata sulla violenza di genere, nonché autrice di Si è sempre fatto così! Spunti per una pedagogia di genere (Edizioni Tlon).
Insieme abbiamo provato a capire cosa possiamo fare, come singole persone, come comunità educante e come società, per andare alla radice della violenza e fare altrimenti, rendere cioè possibile una vita altra, che per molte significa rendere possibile la vita stessa.
1. La Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne è una grande occasione per affrontare una questione che ha carattere di urgenza. Un’occasione che tuttavia, più spesso che no, viene sprecata, insistendo su una narrazione che né restituisce la complessità del fenomeno, né si spinge a indagarne le cause sistemiche.
In che modo la pedagogia di genere può fornire un contributo? Ma ancora prima, che cos’è il genere?
L’attuale narrazione intorno alla violenza di genere insiste definendola “un’emergenza”. È indubbio che lo sia – altrimenti non avremmo una donna morta ogni tre giorni – ma è sbagliato farvi fronte considerandola come se fosse un fatto straordinario.
La violenza di genere, dicono gli studi, ha a che fare con il modo in cui costruiamo le relazioni tra i soggetti e, ancor prima, con il sistema di potere entro cui tutti i soggetti si muovono.
La pedagogia di genere, una branca della pedagogia generale la cui nascita viene fatta coincidere con il celebre volume di E. Gianini Belotti Dalla parte delle bambine, è il sapere che si interroga su quanto l’educazione – e segnatamente gli stereotipi di genere che essa veicola – sia funzionale a confermare quel sistema di potere preesistente o al contrario a metterlo in discussione.
Come dicevo, utilizziamo il 1973 come punto di partenza di questo sapere ma in realtà le riflessioni – anche quelle di Gianini Belotti – sono frutto delle azioni portate avanti dalle attiviste femministe a partire dagli anni ’60.
È in questo periodo in cui vengono messi in discussione i ruoli di genere e di conseguenza, a separare ciò che è inscritto nei nostri geni, nei nostri caratteri sessuali o ormonali – il sesso appunto – da tutto ciò che apprendiamo attraverso l’educazione e la socializzazione.
Possiamo definire il genere come questa “sovrastruttura culturale” che indirizza e incanala le nostre competenze, i nostri tratti personali e peculiarità in ragione dell’appartenenza biologica.
2. Nella nostra società l’educazione delle persone piccole e giovani è una funzione attribuita anzitutto alla scuola e alla famiglia.
Quanto si può fare per imparare, come insegnanti e come genitorɜ, a rimuovere gli ostacoli alla tutela delle pari opportunità e dignità di tuttɜ?
Credo che un’opera di decostruzione sia anzitutto un’operazione individuale: abbiamo bisogno di capire quanto hanno inciso, su ognunə di noi, gli stereotipi di genere. Tuttavia, sono convinta che successivamente sia necessario passare da un discorso individuale a uno collettivo, a mio parere l’unico piano su cui si può innestare un cambiamento.
Come dico spesso ai genitori, unə bambinə può crescere in una famiglia illuminata, sensibile a questi temi; tuttavia si ritroverà prima o poi (insisterei sul “prima”, considerando i tempi in cui viviamo) a fare i conti con la realtà che potrebbe essere molto meno inclusiva e libera dagli stereotipi di quella incontrata tra le mura domestiche.
Riflettere sul piano collettivo implica, inoltre, che tutte le persone giovani possano incontrare ambienti più liberi e liberanti, a prescindere dalla “fortuna” di essere natɜ all’interno di una famiglia più illuminata di altre.
In questo senso, il ruolo della scuola è centrale:
il corpo docente spesso fa tutto ciò che può – nonostante si trovi il più delle volte schiacciato da burocrazia e mansioni che poco hanno a che fare con l’educazione e l’insegnamento – tuttavia servirebbero leggi capaci di garantire, indipendentemente dalla buona volontà delle singole persone, l’attuazione di percorsi dedicati a classi e insegnanti, per promuovere un’educazione libera dagli stereotipi (come, per altro, è richiesto da documenti programmatici tra cui la Convenzione di Istanbul e l’Agenda 2030).
3. Gli stereotipi di genere sono ancora resistenti e tu mostri come il loro impatto non possa essere circoscritto solo alle persone in crescita.
Quali sono gli effetti di questo clima culturale sulle diverse età della vita?
Come dicevo gli stereotipi di genere sono la punta dell’iceberg: quello che contribuiscono a tenere nascosto è il potere sottostante. Non solo esso è rigidamente binario ma contribuisce a porre i due generi in una posizione asimmetrica, e tuttavia apparentemente complementare.
Uomini e donne, in sostanza, avrebbero competenze differenti per bilanciarsi nelle proprie funzioni (per esempio: gli uomini sarebbero portati alle relazioni lavorative, istituzionali e negli affari, mentre le donne sarebbero più competenti nella cura e nelle relazioni intrafamiliari).
Le differenti capacità che il sistema di potere patriarcale tende ad attribuire ai due generi però non sono paritarie ma fortemente squilibrate a svantaggio delle donne, limitate nell’espressione della propria identità considerata a “servizio” di quella maschile.
Anche se il sistema patriarcale pone al vertice la figura dell’uomo (uomo bianco, con un buon conto in banca, etero, con un fisico conforme, ecc.) in realtà esso si rivela una gabbia anche per lui, inscatolato in una maschilità che gli impedisce di mostrarsi per quello che è e lo obbliga a performare un’identità “che non deve chiedere mai”, anche quando magari vorrebbe.
In definitiva, l’attuale sistema di potere nuoce a tuttɜ per il semplice fatto che è calibrato su due identità immaginarie e che di fatto non esistono.
4. Mettendo insieme le prospettive delle due domande precedenti, può essere forse opportuno focalizzarsi su una delle possibili dimensioni della vita delle persone socializzate come femmine: la maternità.
Nella teoria, vale a dire nella cultura predominante, diventare madri è presentato come il compimento di un destino e quindi la realizzazione massima possibile della propria esistenza personale.
Un primo effetto gravissimo è quello di marginalizzare in maniera spesso brutale coloro che non si sottomettono a questa aspettativa, che vengono di fatto escluse dal novero sociale e, in modo più o meno esplicito, stigmatizzate dal punto di vista morale.
Una seconda conseguenza, paradossale, consiste inoltre nella mera vivacità teorica di queste asserzioni: nella pratica chiunque scelga o si trovi a diventare madre non ha a disposizione nessun tipo di supporto sociale o politico alla piena realizzazione né di questa relazione nello specifico, né della propria esistenza di persona in generale.
Quali sono i legami, se ci sono, tra questa situazione e una certa educazione ai ruoli di genere?
La maternità è un “destino di genere”: è il principale mandato delle donne e non a caso i governi – soprattutto quelli di una certa corrente politica – tendono a sottolineare e incentivare con misure economiche questa funzione.
Anche in questo caso gli stereotipi di genere si agganciano agli altri – abilisti e razzisti – perché a ben vedere, nel nostro paese, la si incoraggia solo nei confronti di giovani donne bianche, dotate di un fisico conforme e abile, autonome a livello economico.
Lungi dall’essere un desiderio personale – legittimo come tutti i desideri – la maternità diventa, nella logica di potere che la sottende, uno strumento di controllo: l’educazione indirizza le future donne a questa funzione salvo poi non dar loro alcun sostegno una volta assolta.
Si tratta di un gioco pericolosissimo perché espone tutte le donne alla gogna, sia quelle che si sono sottratte, sia quelle che hanno voluto diventare madri senza annullarsi come persone (e agli occhi del potere patriarcale non saranno mai “buone” abbastanza).
Per sovvertire questa tendenza, in passato, si è pensato che l’unica via fosse abdicare, rimuovere la maternità dalla vita delle persone socializzate in quante donne.
Credo che sia sbagliato: l’unica via è sovvertire la narrazione, normalizzare un’esperienza e creare alleanza tra chi desidera diventare madre anche biologicamente e chi sceglie altre strade, ad esempio “generando parentele” come suggeriva tempo fa D. Haraway.
5. In esergo al tuo libro è riportata una citazione di Grace Murray Hopper per cui “Si è sempre fatto così” è in assoluto la frase più pericolosa. Come spesso quando si propone una critica all’autorità della tradizione, il rischio è quello di essere accusatɜ di voler distruggere senza proporre alternative, ma ciò che tu delinei sono una teoria e una prassi ben diverse, in cui orizzonti e possibilità si ampliano anziché restringersi.
Come si può stare in questo cambiamento, contribuendo a orientarlo nel senso più umano possibile?
Ho incontrato la citazione di Hopper per caso, tanti anni fa, quando lavoravo all’interno del centro antiviolenza della mia città. Da allora quelle parole non mi hanno mai abbandonato e mi hanno aiutato in quel percorso di decostruzione individuale a cui accennavo prima.
In generale credo che il cambiamento (penso ad esempio a quello linguistico, oggi al centro di dibattiti che in alcuni casi sfiorano l’assurdo) sia sempre foriero di nuove prospettive che non soppiantano totalmente le precedenti ma le rielaborano.
Dovremmo ricordarci che non dovrebbero essere le persone ad adeguarsi ai contesti – culturali e reali, poco importa – ma il contrario.
Come esseri umani tendiamo a spaventarci davanti al cambiamento e a usare l’avverbio “sempre” anche per riferirci a situazioni che non sono poi così estese nello spazio e nel tempo.
Pensiamo anche solo ai colori: quando chiediamo a un genitore perché tende a scegliere il rosa o il blu (in ragione al genere del bambinə) è facile sentirsi dare come risposta che “si è sempre fatto così” salvo poi scoprire che quel “sempre” in realtà si situa indicativamente intorno agli anni ’40 del secolo scorso. Prima infatti era consuetudine attribuire i colori in modo diametralmente opposto.
La pedagogia generale – e tutte le sue diramazioni – è una scienza fortemente umana e in questo senso può aiutarci a ri-contestualizzare i percorsi educativi delle persone ricordandoci, attraverso le parole di A. Rich “che il cambiamento è l’unica poesia”.
Immagine di copertina:
wandaproject con illustrazione di Martina Spanu
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.