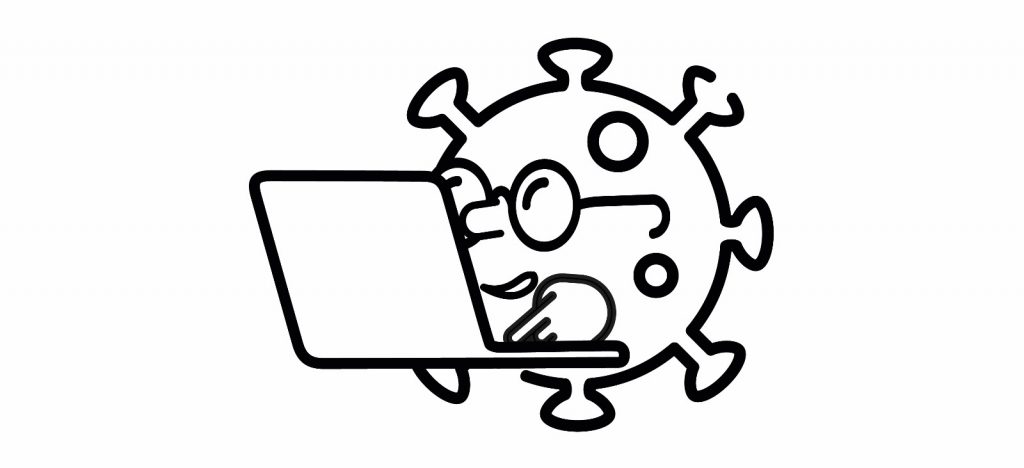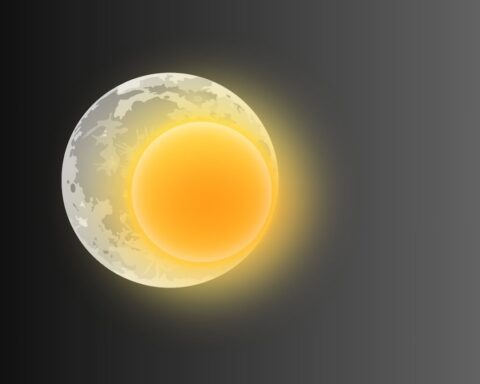Oggi commemoriamo i sacrifici di uomini e donne compiuti contro soprusi e prevaricazioni del loro tempo. Ricordiamo la protesta, lo sciopero, la lotta. Il ricordo diventa celebrazione e la celebrazione si fa festa: travolgente dispositivo di amplificazione dell’appartenenza e senso di collettività.
Oggi parliamo del lavoro, che è stato a lungo il vessillo del popolo nella lotta contro gli abusi di potere nelle grandi narrazioni politiche.
Di cosa parliamo, davvero, oggi?
Ho ventitré anni, e vivo a Genova. Quando si parla di lavoro mi colgono incontrollabili capogiri.
Da qualche anno a questa parte mi trovo gettata in un sistema che non capisco, che è illogico e iniquo, mutevole, anche un po’ sinistro. Ma una cosa l’ho capita, di questo sistema, l’unica regola d’oro: gira velocissimo. Se non stai al passo, sei fuori.
Per tentare di non soffocare, devo momentaneamente mettere in pausa i miei tentativi di riflessione critica sul significato del lavoro nei nuovi, sibillini, rapporti di potere contemporanei: devo sospendere la ricerca del nemico nascosto. Non c’è tempo.
Le grandi narrazioni non caratterizzano più il tempo in cui vivo. Nel mio tempo le narrazioni, o quel che ne resta, si sono rimpicciolite, frammentate, dissolte. Il lavoro come vessillo, allo stesso modo, si è frammentato, dissolto.
Cosa si festeggi, invero, il primo maggio, è qualcosa che tristemente non riesco ad afferrare.
Quello che percepisco è che oggi celebriamo una liturgia svuotata del suo significato, così come accade per molti di noi anche in occasione delle feste religiose.
Come dicevo, ho ventitré anni e vivo a Genova. Per me il lavoro è cominciato quando in seconda media ho organizzato la gita scolastica per la mia classe, perché la mia scuola aveva sospeso i viaggi d’istruzione come protesta contro il decreto Gelmini. Che senso ha privare i ragazzi di una tale gioia, per lottare anche in difesa dei loro diritti, mi chiedevo. Non avendo tempo per trovare le risposte alle troppe domande che da allora ho iniziato a farmi, ho dato la precedenza all’attività – letteralmente – all’essere attiva, presente, nel sistema. Questa non è solo la mia storia, ma è la storia della mia generazione: siamo quelli che provano ad arrangiarsi. Perché essere attivi, fare le cose, restituisce la sensazione di non essere del tutto inglobati.
È questo il nostro lavoro: arrangiarsi, ognuno per sé. Costruirsi delle logiche, dei metodi. Inventare il proprio impiego e adattarlo ai mutevoli spazi fluidi che permeano il sistema del nostro tempo.
Il problema piuttosto evidente è che le cose vanno male; ma la contingenza vuole che ci preoccupiamo quasi unicamente della nostra sopravvivenza. Tutte le domande, le riflessioni critiche, le indecisioni, non trovano spazio. Da quando le grandi narrazioni si sono dissolte, non ci sono più amici né nemici, parti da tenere, vessilli che valga la pena sbandierare.
Appartenenza, senso di collettività? Sempre meno, sempre più difficili da concepire, alimentare, coltivare.
Cosa festeggiamo oggi? E come festeggiamo?
Succede che mia madre, dottoressa attiva in uno dei principali ospedali di Genova, ha contratto il Coronavirus in corsia.
Succede che un’amica gallerista, libera professionista, ha pagato di tasca sua lo stipendio di aprile a una stagista che altrimenti avrebbe dovuto licenziare.
Succede anche che molti artisti, amici, non retribuiti e men che meno riconosciuti dal sistema in quanto artisti, sono disposti a collaborare a un progetto di beneficienza devolvendo le proprie opere per aiutare la sanità genovese a far fronte all’emergenza attuale.
Viviamo in un sistema fatto di cortocircuiti: l’impegno sociale, la solidarietà, l’onestà delle proprie posizioni sembra che girino a vuoto. Il lavoro stesso, viene da domandarsi, a chi giova?
Ecco, il quadro non è affatto semplice. A pensarci, non si trova alcuna soluzione.
Ma volevo dire che c’è anche un’altra cosa che ho imparato, per ora, da questo sistema: pensare alla soluzione è impossibile, ma sentire cosa mi restituisce un valore, nel mio lavoro, quello lo posso fare. E sento sempre più chiaramente, e sempre meglio, che la direzione è investire anima e corpo nella ricerca di relazioni, di collettività.
Più coltiviamo la collettività, la socialità, gli scambi umani, più troviamo complici, alleati e interlocutori. Possiamo creare nuovi discorsi ma soprattutto nuove narrazioni. Le narrazioni crescono nella collettività, non nell’individualità.
In definitiva, in questo appuntamento emotivo che è la festa del Lavoro, il mio invito è di farsi delle domande vere.
Fermarsi, farsi domande, e condividerle.
Approfittiamo del valore di una festa: proviamo a sentirci parte di una comunità. Qualsiasi cosa significhi oggi.
Immagine di copertina:
Ryoji Iwata
Scrivi all’Autorə
Vuoi contattare l’Autorə per parlare dell’articolo?
Clicca sul pulsante qui a destra.