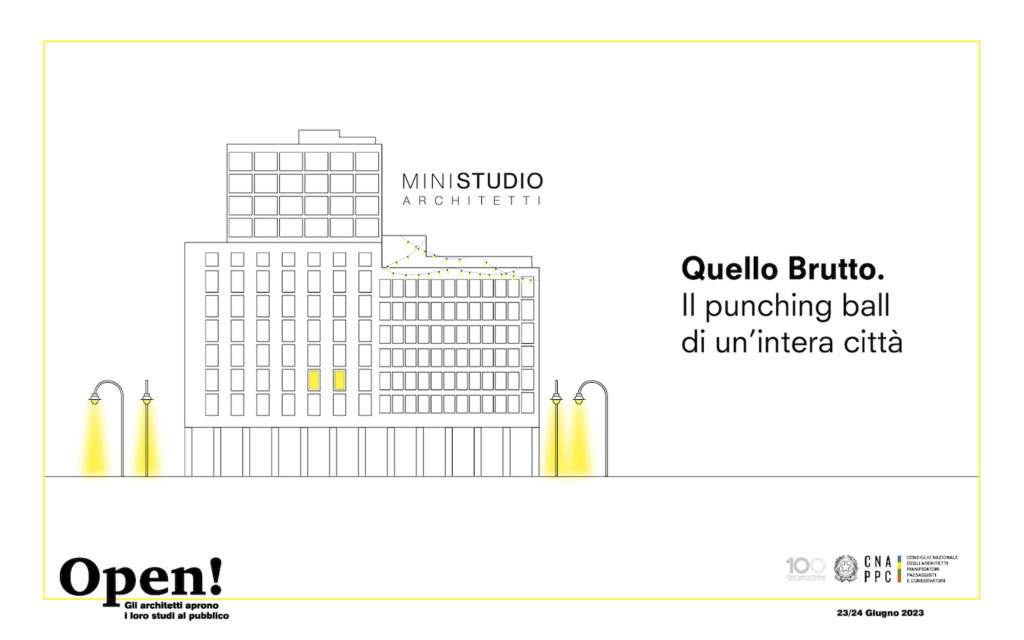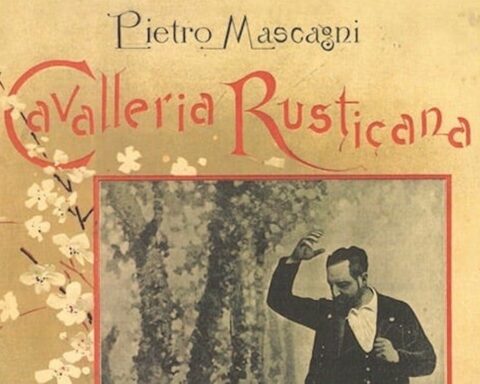La prima volta che misi piede a Genova deve essere stato intorno ai 6 anni per entrare in quella scatola edulcorata e un po’ asettica che è l’acquario. Al di là di una grande ondata blu e riflessi sul vetro non ricordo molto altro.
Per chi viene dalle province, dalle cittadine e dai paesini liguri, Genova appare come una città-stato con una propria giurisdizione, avvolta da un’aura di magica superbia che la rende impermeabile al resto della regione. Dilaga, pertanto, la comune sensazione di sentirsi furesti (o babbani se fossimo a Hogwarts), cioè i liguri non genovesi che si sentono sempre un po’ incantati e un po’ estranei alla vita e persino alla mentalità del capoluogo.
Fin qui nulla di nuovo o profetico, no?
Almeno nulla di nuovo per chi, come me, ha vissuto e vive Genova come una meta concreta di opportunità (Università in primis, e non solo) ma al contempo la sente sempre un po’ scivolare via dalle mani forse per l’impossibilità di affondare radici permanenti e perché Genova del nostro passaggio nemmeno pare accorgersi, matrigna indifferente.
“Genova verticale” scriveva Caproni, io dico “Genova pendolare”. Sì, perché Genova è da sempre un vero e proprio porto di mare: un crogiuolo di lingue, persone e identità che la attraversano arricchendo la sua proverbiale complessità.
Ma Genova ha memoria e consapevolezza che la sua ricchezza proviene anche da fuori?
Mi sono imbattuta nell’etnocentrismo genovese quando, con timorosa reverenza, mi apprestai ad assaggiare la famosa e impareggiabile focaccia. Buonissima è logico. Nulla a che vedere con quella spugna alta e gommosa che noi ponentini osiamo chiamare focaccia.
Io d’altro canto pensai che fosse un’abitudine aliena e sacrilega inzupparla nel cappuccino alla stregua dei turisti che in via Balbi alle 11:30 del mattino pasteggiano a pizza e cappuccio.
Siamo sempre gli alieni di qualcun altro è evidente. Ho incontrato altre creature disorientate e disorientanti quali gli spezzini che, come Balto, vivono una perenne disforia identitaria – “Non è ligure, non è toscano” – a causa delle cantilene patriottiche che si respirano a Zena.



Già, ma qual è il punto di questo articolo? Un casus belli per scatenare l’ennesima diatriba campanilistica?
Non direi. La mia è una dichiarazione d’amore nei confronti di Genova, ma non di un amore romanticamente idealizzato bensì di un sentimento maturo ed equilibrato in cui ciascuno degli amanti coinvolti fa la sua parte (presumendo che il mio amore sia ricambiato).
Ciò che voglio dire è che mi piacerebbe che lo sguardo di Genova si spostasse lungo i “margini” oltre i suoi confini per meglio cogliere e apprezzare lo sforzo che i non genovesi (e non solo) compiono ogni giorno per venire a lavorare, studiare, curarsi o anche solo per godere di una gita fuori porta.
Il treno è l’emblema dell’attesa ed è una promessa, ma è anche il non-luogo dove il tempo perde i suoi connotati facendo sentire chi viaggia materia grezza, in divenire tra ciò che era e ciò che sarà.
Il cervello fa strambi viaggi psichici quando ha tempo per pensare.
In soldoni, questo è un piccolo (per molti senz’altro trascurabile) J’accuse: mia adorata Genova, accogli l’appello di una tua cittadina d’affezione e ascolta la voce di tuttз quellз che calpestano il tuo suolo per più o meno tempo. Aiutaci a non sentirci ospiti occasionali e ascolta le nostre istanze: non siamo solo l’incasso della giornata al bar o in negozio, non siamo solo quella massa indistinta che congestiona stazioni e autostrade.
Mia cara Genova, oltre a guardarci di sfuggita e volerci presto “fuori dal belino”, vorremmo essere vistз.
Questo articolo è uno sfogo sulle mie personali percezioni, ma non cambierà la nostalgica speranza di rivederti ogni volta che sarò in attesa di tornare a casa sul binario 11 di Principe.


Immagine di copertina:
Via Balbi, Genova. Foto di Onur Kurt